Sigur Rós - Takk…
Un viaggio onirico. È così che amo definire la musica dei Sigur Rós: un morbido, tormentato, sinuoso viaggio onirico che lentamente si insinua e prende forma dentro di te. È una musica che proviene dalla ghiacciata terra islandese, piccola, isolata, ma che ci ha fatto conoscere artisti quali Björk o i múm (giusto per citare un paio di esempi) e, ora, questo gruppo che già dal suo secondo disco, Ágætis Byrjun, ha rapidamente raggiunto la fama mondiale, confermata ancor più dal successivo capolavoro ( ) (due parentesi vuote, nessun titolo per i brani); e ora abbiamo tra le mani anche Takk…, quarto lavoro, spasmodicamente atteso fino a settembre, di questi folletti islandesi che hanno saputo incantarci con la loro nordica magia.
È raro, nel 2000, incontrare gruppi in grado di creare quasi una categoria a sé stante, un tipo di fluido sonoro che può essere sì confrontato con altre creazioni, ma di cui appare senza ombra di dubbio l’estrema originalità. Già Jimmy Page sperimentava l’archetto sulle corde della chitarra; ma non ne faceva lo stesso uso di Jónsi Birgisson, che alterna melodiosi arpeggi a lunghi tormenti di chitarra scaturiti dal lento muoversi dell’archetto che non smette di sviscerare i suoni più eterei, più inaspettati, più ipnotizzanti, morbidi ma dolenti; ed è uno spettacolo vederlo lì, sul palco, il viso che appare così contratto, malinconico, sfinito (espressione accentuata dal suo sfortunato occhio cieco), il braccio destro che si muove avanti e indietro impugnando l’archetto, l’intera sua persona completamente avvinta dalla propria musica. La sua voce, quasi femminea, morbida, penetrante, accompagna in modo perfetto il sinuoso espandersi musicale.
Per capire quanto ogni strumento sia perfettamente amalgamato con gli altri, formando un unico magma sonoro, ora più minimale, ora più corposo, un tutt’uno anche con la parte vocale, basti pensare che Birgisson, dopo aver scritto, nei primi due dischi, i propri testi in islandese, in ( ) ha scelto di cantare in hopelandish, una lingua inventata, misto tra islandese, inglese e suoni senza significato. Nell’ultimo lavoro, Takk… (che nella loro lingua madre significa semplicemente “Grazie…”), ha scelto di abbandonare questa sua creazione. Colpa del passaggio a una major come la EMI, mormora qualcuno con malizia; è anche vero che questo disco suona meno triste, più ottimista del precedente capolavoro; ma i Sigur Rós non abbandonano assolutamente il loro personalissimo modo di far musica, per nulla commerciale, io penso. Lo chiamano dream pop: nome piuttosto azzeccato, visto che fin dai primi, tremanti istanti dell’intro ciò che viene più spontaneo è abbandonare la testa sul cuscino, immobili, e chiudere gli occhi. Per lasciarsi poi catturare dalle suggestive note di basso di Glósóli, su cui si innestano lievi melodie e l’angelica voce: per tutta la canzone un andamento morbidamente cadenzato, che culmina in un crescendo distorto, così raro nei loro brani, ma di intensità così preziosa.
Sembra un carillon lo strumento che improvvisamente chiude la canzone, per lasciare spazio alle note di pianoforte che introducono la splendida, ma anche forse la più orecchiabile, Hoppípolla, dove gli archi occupano ampio spazio senza sembrar per nulla di troppo; lo stesso quartetto di archi Amina, che ha sempre accompagnato il gruppo sia nelle produzioni in studio sia nelle esibizioni dal vivo, è protagonista anche in Sé Lest, dove potrebbe quasi confondersi amalgamandosi completamente con la voce, e nella lunghissima Mílanó: il titolo si riferisce proprio alla città dove è nata questa canzone, durante un’improvvisazione live.
Gong, il brano forse dal maggiore impatto, colpisce già per la base ritmica, per i vocalizzi, per il turbine disperato in cui infine si dissolve; ma il vertice dell’album è, per me, Sæglópur: una canzone che forse si discosta in parte dallo standard del disco, dove, dopo i primi due minuti di solo pianoforte, lievi inserimenti vocali, campanellini, rumori, improvvisamente tutto si sconvolge coi brividi della chitarra suonata con l’archetto, note basse del pianoforte, batteria molto più movimentata della consueta morbida lentezza, ma che sa quando intervenire con sapiente devastazione, la voce sempre a creare la propria eterea melodia.
Un’alternanza di levità e di corposità, di dolcezza e di momentaneo sfogo, dato da un amalgama sonoro dove ogni strumento si confonde nell’altro; ovunque un immenso potere di suggestione; tutto questo in un disco che è un ulteriore traguardo di una band forse unica oggi, che ha realmente folgorato chi ha avuto la fortuna di vederla dal vivo (quattro date in Italia quest’anno), anche chi prima non riusciva a restare ipnotizzato dai loro suoni.








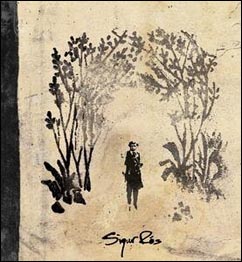










Commenta